Amici verso i quali ho più di una ragione di riconoscenza, mi hanno invitato a partecipare, lunedì sera, all’incontro organizzato dal Circolo del PD al quale sono stato per un certo tempo iscritto, per intervenire alla discussione sui risultati elettorali delle Elezioni Regionali in Emilia-Romagna, aperta da una puntuale relazione di un giovane ricercatore dell’Istituto Cattaneo.
Il mio intervento aveva come riferimento la dimensione territoriale del risultato, chiave sempre meno secondaria nello spiegare i comportamenti elettorale spingendosi un po’ oltre la soglia della cronaca e dei giudizi – spesso superficiali – sull’efficacia della comunicazione. Comunque, l’unica rispetto alla quale io avessi titolo per intervenire.
I rossi e i blu.
Una tesi del Cattaneo – forse la principale - è quella che le elezioni emiliano-romagnole riportano il panorama politico-elettorale verso una configurazione esplicitamente bipolare, tornando dopo qualche sussulto alla configurazione di dieci anni fa, con pesi degli schieramenti sostanzialmente immutati e divari assoluti ravvicinati.
La logica dei “rossi e i blu” con i quali abbiamo cominciato a familiarizzare a partire dalle Presidenziali USA, sembrano rappresentare anche da noi non più una brutale semplificazione, inadatta alla finezza del nostro palato, ma la rappresentazione plastica di quel che viene percepito come la posta in gioco del confronto elettorale.
Piuttosto va registrato come, rispetto alla tradizione del bipolarismo (americano) dove gli schieramenti si contendevano la rappresentanza della sezione centrale del corpo elettorale, il confronto attuale sembra giovarsi della radicalizzazione sempre più spinta delle posizioni.
Nelle elezioni e forse non solo. E c’è fa farsene sorgere qualche preoccupazione, se dobbiamo registrare la ricerca di uno spazio mediano che risalta nelle parole di un vecchio estremista come Adriano Sofri. In altro contesto, Sofri lamenta come “il campo delle relazioni si sia andato restringendo ai due poli opposti: ”il genocidio da punire dal fiume al mare” e “il diritto senza riserve di Israele all’autodifesa”. Tutto è consumato, a ciascuno il suo.”
Di questa radicalizzazione dei comportamenti elettorali e dei pensieri politici sottostanti, pensieri sempre più veloci e affidati alla risposta intuitiva, al “sistema 1” per dirla a là Kahneman, la distribuzione spaziale è una manifestazione molto evidente ma forse, al tempo stesso, è in grado di suggerire anche qualche “pensiero lento”.
La rappresentazione dei rossi e dei blu delle presidenziali statunitense, rappresentata alla grana delle singole contee, mostra un panorama desolante: un mare rosso dove sembrano emergere pochi scogli affioranti blu, che solo nella megalopoli della East coast assumono la consistenza di un’isola. Isolate e assediate da una marea rossa che copre il 95% e più delle contee USA, le realtà urbane democratiche sembrano mostrare tutta la loro (la nostra) fragilità.
Rovesciata nelle consistenze (oltre che nella attribuzione dei colori) ma non nel significato della divaricazione territoriale, ci appare molto eloquente anche la rappresentazione dei recentissimi risultati elettorali delle regionali dell’Emilia-Romagna, sempre se la guardiamo nella sua elementare verità della prevalenza dei rossi e dei blu, di segno questa volta inverso.
Qualche sfumatura in più, tuttavia, andrebbe colta. Alla elementare contrapposizione tra aree urbane e rurali, meglio tra sistema metropolitano regionale e aree interne, si aggiunge almeno, l’indebolimento della connotazione “progressista” del voto nei sistemi urbani “di confine”, le città di Piacenza, Ferrara e Rimini e le loro più strette periferie, nelle quali la spinta propulsiva “dell’Emilia Rossa” si attenua e prende spazio la contaminazione, “il contagio” con i sistemi socioeconomici e le sub culture politiche di altre regioni.
Comunità in rilievo.
Consentitemi però, di spostare la mia attenzione – e con essa il mio punto di vista – verso i rilievi Appenninici entro i quali, sempre più si è esercitata la mia esperienza professionale e anche, vorrei dire, il mio impegno civile.
Se è vero che sempre più spesso guardiamo con apprensione alla geografia per riconoscere le difficoltà e gli insuccessi che una proposta politica “progressista” riscuote nei territori lontani dalle maggiori concentrazioni di benessere, i luoghi urbani e metropolitani, Tanto più lo dobbiamo fare riguardo ai luoghi, come le montagne degli Appennini e delle Alpi dove si giocano le questioni “di avanguardia” della risposta alla sfida climatica e all’inverno demografico.
Fa allora davvero piacere - a me almeno - cogliere le diversità, le anomalie che si presentano nel panorama della espressione politica dei territori della montagna emiliana e romagnola come ce le hanno restituite le elezioni di novembre.
Tra tutte sottolineo quella clamorosa che il gioco dei rossi e dei blu presenta nelle i montagne reggiana e modenese, pur così vicine e simili nella loro struttura economica, sociale e territoriale ma mai tanto diversificate nei risultati elettorali.
Una montagna modenese che senza incertezze esprime la propria distanza dal sentimento politico della regione colorandosi di un blu, uniforme e cupo; una montagna reggiana dominata – pur con qualche eccezione – da un orientamento decisamente progressista che ha concorso a dare il segno della eccezionalità del voto reggiano che porta in Assemblea Legislativa cinque candidati del fronte progressista sui sei posti disponibili in totale.
Vorrei trattenermi dal pensare – e soprattutto dal dire - che questa divaricazione sia (anche) l’esito di dieci anni di politiche accorte e lungimiranti che hanno interessato il nostro appennino, all’insegna della montagna del latte; poi sotto quella di una montagna dei saperi che si misura con un cultural divide assai più pronunciato di quello del reddito nel marcare le diseguaglianze dei territori non urbani e, come abbiamo visto, anche la determinante più forte delle differenze di scelta degli elettori.
Vorrei essere più pudico e prudente ma poi non ce la faccio e, come a Lucy van Pelt, mi viene di affermare “Mi sforzo di non avere sempre ragione ma non ci riesco”.
Il tema un poco più generale che voglio sottoporre alla vostra attenzione è quello che “le politiche influiscono sulla politica” anche se questa nella sua semplificazione comunicativa non sembra darsene troppa preoccupazione.
I reggiani, radicati e spaesati.
Ho avuto la ventura di conoscere in anteprima e di discuterne con gli autori, gli esiti di una rilevazione sul sentiment politico e sociale dei cittadini della provincia di Reggio Emilia, con la quale Unindustria ha ripreso dallo scorso anno una sua antica tradizione. Esiti che saranno presentati all’evento “di fine anno” che il mondo industriale celebra il prossimo 11 dicembre e che non posso certo qui anticipare (spoilerare?).
Tra le caratteristiche significative, nel metodo, anche il fatto che la rilevazione coglie dal punto di vista territoriale, una tripartizione della provincia nella quale molto mi riconosco e che portato Unindustria a condividere preliminarmente gli esiti della rilevazione con i tre Sindaci di Castelnovo, Reggio Emilia e Guastalla. Ma su questo dovremo tornare.
Qui mi interessa sottolineare – per i suoi possibili riflessi sui comportamenti elettorali, oltre quelli già espressi che abbiamo recentemente registrato – lo scarto evidente (e non facilmente interpretabile) tra un orgoglioso e convinto radicamento territoriale che ha la sua essenziale matrice nel mondo della produzione, e un sentimento di incertezza almeno altrettanto marcato riguardo alla evoluzione in corso nella nostra società.
Tanta l’incertezza che la metà quasi degli intervistati (in città) dichiara di ignorare le dimensioni dei fatti più rilevanti che hanno caratterizzato le prime due decadi del nuovo secolo, l’immigrazione straniera nella prima, la presenza universitaria nella seconda; ancora più preoccupante è il fatto che la stragrande maggioranza di quelli che una idea ce l’hanno, la hanno sbagliata, clamorosamente.
Questa tensione implicita tra radicamento delle convinzioni e incertezza (e ignoranza) del contesto entro il quale le convinzioni vanno esercitate, proponga al discorso pubblico un impegno gravoso, molto più profondo e molto più esteso di quello esercitato ordinariamente dalla comunicazione politica.
Un impegno che molto ha a che fare con le politiche, cioè con la capacità di agire efficacemente sull’ambiente economico, sociale e culturale entro il quale prendono vita le decisioni sulla partecipazione elettorale.
Certo, l’impegno sulle politiche richiede una costanza di applicazione, lunga nel tempo, quando la agenda politica preme invece per comunicazioni e (pseudo) soluzioni immediate.
Il territorio, verso cui tornare.
Vorrei tornare alla dimensione territoriale che mi è più vicina per competenza e per consuetudine.
Dicevo della organizzazione tripartita del survey confindustriale e della sua origine in una interpretazione della struttura territoriale della nostra provincia (conseguente alla interpretazione della struttura territoriale della Regione) attorno alle tre realtà della Montagna, della Città e della Pianura, forse un po’ primordiale ma che mi sento di dover sostenere, avendo contribuito a formarla.
Una interpretazione prevalente delle geografie economiche e politiche del nostro Paese nella contemporaneità insiste sulla visione - semplificata ma efficace – di una sua sostanziale partizione tra metropoli e aree interne, pur con tutte le sfumature che i due termini possono conoscere al loro interno.
Altri - Arturo Lanzani, per esempio – sostengono l’esistenza di una “Italia di mezzo” non riconducibile ad alcuna delle due polarità, che meglio interpreterebbe la natura di territori estesi, anche di intere regioni, come per il Friuli o le Marche.
Non so dire se l’Italia di mezzo conoscerà la fortuna della Terza Italia, quella che con Bagnasco, Fuà e Beccattini, ha interrotto il più antico dualismo territoriale tra Nord e Sud.
Si nota però che nella rappresentazione del territorio dell’Emilia-Romagna, la coppia Sistema metropolitano – Aree Interne non è sufficiente ad attribuire significato a tutte le realtà territoriali riconoscibili.
Non ci riesce per quanto si voglia intendere la condizione metropolitana estesa a ricomprendere nel primo caso oltre le città capoluogo anche le loro cinture, a formare un sistema pluripolare che – in due distinti segmenti – attraversa la regione e ne rappresenta il core metropolitano; e oltre a queste le città del confine che presentano morfologie e assetti funzionali molto diversi. Neppure quando nelle aree interne si comprendano, oltre all’Appennino, i territori deltizi del Po.
Fuori dai giochi rimane una significativa porzione della pianura centrale emiliana – nelle province di Reggio Emilia e Modena, in particolare – ascritte sino a pochi decenni or sono al novero delle aree svantaggiate, delle “basse” e rivelatesi nel passaggio di secolo la nuova frontiera dello sviluppo industriale regionale; territori ricchi di multinazionali tascabili ma ancora fragili nella infrastrutturazione civile e sociale della propria armatura urbana, distinta però e non riconducibile a quella della Via Emilia.
Qui, ci dicono i survey confindustriali, lo spaesamento della contemporaneità è più forte e più forte e la difficoltà a riconoscere e costruire una propria identità che, se non vuole scivolare nell’oscuro sentimento della nostalgia, deve esplorare il campo incerto ma affascinante delle strategie, delle politiche di sviluppo territoriale dunque.
Un orizzonte che per prima cosa impone di superare quel municipalismo che è stato il fondamentale riferimento politico della tradizione democratica emiliana ma che spinge ormai verso il rischio di irrilevanza la politica locale.
Per questo la tripartizione della provincia non è un esercizio di geografia ma la proposta di una visione territoriale di assoluto rilievo per le politiche, dunque per la politica. Una visione che chiama i tre Sindaci della Città capoluogo, di Castelnovo ne’ Monti e di Guastalla ad assumere iniziative di più alto profilo che, con approccio inclusivo e sensibilità plurale alle differenze, si propongano di dare risposte – forse meno immediate ma sicuramente meno contingenti – allo spaesamento e alle incertezze dei cittadini.
Anche in una regione come l’Emilia-Romagna che ha potuto sin qui vantarsi come nessuna altra dei suoi successi competitivi come della tenuta della sua coesione sociale. Che deve però fare i conti con il suo essere “il Land più meridionale della Germania” che suona oggi assai meno rassicurante che un anno fa.







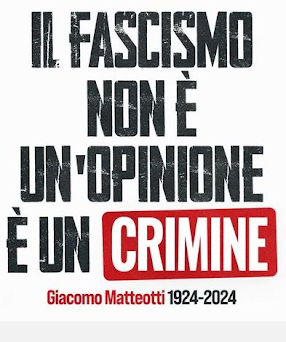




Nessun commento:
Posta un commento
Scrivi il tuo nome, altrimenti l'autore apparirà come "Anonimo"